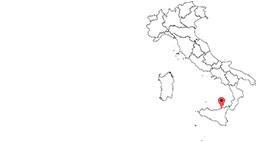In questo periodo milioni di cittadini si trovano alle prese con la dichiarazione dei redditi per determinare l’IRPEF da pagare. Ma cosa è l’IRPEF”? Come si calcola? Chi è obbligato a presentare la dichiarazione e chi invece ne è esonerato? Questo articolo ha l’obiettivo di rispondere a tutte queste domande, con un linguaggio semplice, anche chi non è tra gli addetti ai lavori.
È bene premettere che l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è un’imposta diretta, personale, progressiva e annuale che grava sul reddito delle persone fisiche residenti e non residenti in Italia.
Perché l’IRPEF sia dovuta, è necessario avere un reddito appartenente a specifiche categorie, previste dall’art. 6 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi):
- Reddito fondiario: presuppone il possesso di immobili in Italia (Terreni, fabbricati ecc.).
- Reddito di capitale: presuppone l’Impiego di capitali che generano proventi.
- Reddito da lavoro dipendente: presuppone un rapporto di subordinazione o assimilato.
- Reddito da lavoratore autonomo: presuppone un’attività professionale o artistica.
- Reddito d’impresa: presuppone l’esercizio di impresa con organizzazione e continuità.
- Redditi diversi: rappresentano redditi non classificabili altrove ma fiscalmente rilevanti.
Esistono anche casi in cui, al ricorrere di determinate condizioni, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Le principali tipologie di reddito che possono beneficiare dell’esonero sono:
- Esclusivamente da abitazione principale;
- Esclusivamente da lavoro dipendente di un solo datore di lavoro o pensione;
- Esenti da IRPEF (es. borse di studio, pensioni di invalidità, pensioni sociali, indennità INAIL, ecc.);
- Soggetti a imposta sostitutiva ( interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico);
- Soggetti a ritenuta a titolo d’imposta ( interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili ecc.).
Per calcolare correttamente l’IRPEF è innanzitutto necessario determinare il reddito complessivo, ovvero la somma di tutti i redditi percepiti dal contribuente nell’anno solare. Successivamente, è necessario sottrarre gli oneri deducibili (es. contributi previdenziali e assistenziali, assegni periodici al coniuge separato, ecc.) per ottenere il reddito imponibile. Una volta che abbiamo il reddito imponibile si provvede al calcolo dell’IRPEF applicando aliquote diverse in base agli scaglioni di reddito. Gli scaglioni in vigore dal 2024 sono tre:
- Fino a 28.000 €: aliquota del 23%;
- Da 28.001 a 50.000 €: aliquota del 35%;
- Oltre 50.000 €: aliquota del 43%.
Il risultato di questo calcolo ci dà l’IRPEF lorda, alla quale si applicano le detrazioni fiscali, che riducono l’imposta da versare (da non confondere con le deduzioni, che agiscono sul reddito imponibile). Le principali detrazioni sono:
- Per familiari a carico (coniuge, figli, altri): spettano se il familiare nel 2024 ha avuto un reddito complessivo non superiore a 840,51 € al lordo degli oneri deducibili (il limite sale a 4.000 € se si ha a carico figli di età non superiore a 24 anni). La detrazione varia in base al reddito complessivo del contribuente: Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino a 800 €, decrescente all’aumentare di un reddito complessivo di 15.001 €. Se il reddito supera 80.000 €, la detrazione si azzera. È inoltre prevista una detrazione teorica di 950 € per ciascun figlio di età pari o superiore ai 21 anni, rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza. Con reddito oltre 95.000 €, la detrazione si azzera. Infine, per altri familiari a carico, è prevista una detrazione teorica pari a 750 €, da rapportare anche in questo caso al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza. Come nel caso del coniuge a carico, la detrazione per altri familiari a carico si azzera oltre gli 80.000 € di reddito complessivo.
- Per lavoratore dipendente: si applicano ai titolari di contratto di lavoro subordinato. Le detrazioni variano in base al reddito complessivo: se il reddito è fino a 15.000 €, la detrazione può arrivare fino a 1.955 €. È previsto un importo minimo garantito di 690 € (oppure 1.380 € per i contratti a tempo determinato); Se il reddito è tra 15.001 e 28.000 €, la detrazione parte da un massimo di 3.100 € e decresce fino ad un minimo di 1.910€; se è tra 28.001 e 50.000 € la detrazione è pari a 1.910 €, ma si riduce proporzionalmente fino ad annullarsi al superamento dei 50.000 €.
- Per lavoratore autonomo: spettano a chi esercita un’attività professionale o d’impresa in forma individuale non in contabilità ordinaria. Decrescono progressivamente all’aumentare del reddito: Se il reddito complessivo è fino a 5.500 €, spetta la detrazione piena di 1.265 €. Per redditi superiori a 5.500 € e fino a 28.000 €, la detrazione è calcolata con una formula che parte da 1.265 € e decresce fino a 500 €. Da 28.000 € a 50.000 €, la detrazione è pari a 500 € e decresce linearmente fino ad azzerarsi a 50.000 €.
Oltre alle detrazioni, esistono anche gli oneri detraibili, ovvero spese sostenute dal contribuente che consentono, di ottenere una detrazione sull’IRPEF, in genere pari al 19% della spesa, entro certi limiti di reddito, salvo alcune eccezioni (es. i bonus sulle ristrutturazioni, le cui detrazioni oscillano tra il 36% e il 50% della spesa).
Fra gli oneri detraibili troviamo ad esempio le spese sanitarie, per l’istruzione, per assistenza a persone non autosufficienti, per mezzi di trasporto per disabili e così via. Sottraendo detrazioni e oneri detraibili dall’IRPEF lorda si ottiene l’IRPEF netta. Per arrivare all’IRPEF da versare in via definitiva dobbiamo effettuare ulteriori operazioni: se sei un lavoratore dipendente o pensionato, infatti, il datore di lavoro o l’ente pensionistico agisce da sostituto d’imposta e ha già trattenuto ogni mese delle somme a titolo di IRPEF. All’IRPEF netta, dunque, è necessario sottrarre le ritenute subite (in busta paga o cedolino). Vanno sottratti anche eventuali crediti d’imposta spettanti (per esempio: imposte estere già pagate, bonus fiscali, crediti da anni precedenti).
Riepilogando, la formula complessiva per arrivare all’IRPEF segue progressivamente il seguente calcolo:
Reddito Complessivo − Oneri Deducibili = Reddito Imponibile;
Reddito Imponibile con applicazione delle aliquote progressive = IRPEF Lorda;
IRPEF Lorda – Detrazioni d’imposta | Oneri detraibili = IRPEF Netta;
IRPEF Netta – Altri crediti d’imposta | ritenute già subite = IRPEF da versare;
L’IRPEF può essere infine versata tramite modello F24 in due rate: la prima, che comprende il saldo IRPEF dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno in corso, è pagabile entro il 30 giugno (o 31 luglio con maggiorazione dello 0,40% o in 5 rate), la seconda, invece, è pagabile entro il 30 novembre. È possibile versare l’importo in un’unica rata entro il 30 novembre dell’anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 €.